Un mio modesto ricordo di Fabrizio de André
Forse parlare di un cantautore genovese in un sito di un partito il cui scopo è l’indipendenza della Venetia può apparire fuori luogo. Ma chi avrà la pazienza di leggere queste poche righe capirà che fuori luogo non è.
Tout se tient.
Quando de André morì, dieci anni fa, io ero a Princeton, negli Stati Uniti. La piccola città universitaria era coperta di neve e la mia anima di indicibile tristezza. Ché avrei voluto conoscerlo, questo poeta anarchico e malinconico, che percorreva il Far West e la Sardegna e infiniti altri luoghi veri o immaginari, presenti o passati, con le sue bellissime canzoni. Colui che aveva dedicato, genovese come me, alla “cima”, un nostro piatto tradizionale, una delle più belle canzoni del Novecento, in genovese naturalmente, un volo pindarico, nel senso positivo, proprio della poesia, dalla cucina alla metafisica, alla vita, alla morte, al nostro destino di mangiatori, senza sapere da chi noi stessi saremo mangiati.
Avrei voluto conoscerlo perché in qualche modo mi avrebbe parlato, anche senza dirmi nulla di questo, di me stesso, della mia “genovesità” e dell’Esser-ligure in generale, qualcosa che difficilmente possiamo esprimere a parole, ma certo nella vita, nei gesti, nei modi di fare e di pensare.
Come credo sia per un veneto, anzi senz’altro lo è.
Una variante dell’essere umano in generale, legato ai luoghi in cui nasce e cresce, e che lo formano ben aldilà di una lingua, delle possibilità di spiegazione linguistica di questo “essere”, di qualche stereotipo (saremo davvero così tirchi, noi genovesi?), di un amore per la propria terra che quando è radicale e forte si rovescia, naturalmente, in un amore altrettanto grande per l’umanità intera.
Per ogni terra ed ogni luogo.
Per quello sono stato colto da nausea al vedere i servi sommessi e mesti e astutissimi di ITA, Fazio e due coboldi vagamente somiglianti ad essere umani di sesso femminile, dagli schermi RAI, la cooperativa di ITA volta a creare Raggirati, Abbindolati, e Ingannati, annunciare un ferale banchetto mediatico serale con le spoglie di Fabrizio, ché i morti si sa non possono difendersi.
Non tutti.
Qualcuno vive nella memoria dei vivi, e allora vorrei ricordare che de André seppe condannare molte delle menzogne che di ITA fanno i fondamenti. Per prima, la prima guerra mondiale, uno dei peggiori macelli del Novecento, un secolo di massacri seriali; cantò i poveracci mandati ad uccidere e morire senza sapere perché, sepolti nei campi di grano, all’ombra dei papaveri rossi.
Allegramente, a volte tristemente anarchico, Fabrizio mise poi alla berlina i giudici giustizialisti, le leggi cieche e le logiche mafiose e le “carceri d’oro”, ovvero le logiche che sorreggono non tanto la mafia quanto ITA, ché la prima è emanazione diretta, ipostasi della seconda.
Cantò in versi surreali e surrealisti gli anni Settanta e gli anni Ottanta, mostrò umana pietà, prima che cristiana, nei confronti dei suoi rapitori sardi, seppe sublimare passione e terrore in versi come quelli dell’”Hotel Supramonte”.
Condannò perfino i massacri di Stato degli indiani d’America, altra sua passione. Chivington aveva 43 anni, non era un “generale di vent’anni”, quando si macchiò del massacro di Sand Creek, nel 1864. Ma questo “felix error” ci dice molto su quale violenza de André voleva condannare.
Restituì fama e dignità alla lingua genovese, e entrò nell’umanità di tanti, un transessuale brasiliano, un secondino napoletano, un rapitore sardo, tanti borghesi grandi e piccoli e medi della mia, della nostra città, Genova, e allegre prostitute d’ogni età.
Restituì al loro essere uomini perfino chi non aveva mai conosciuto, un Piero che muore nel massacro del 1914-1918, coloro che quel “generale di venti anni” fece massacrare a Sand Creek, indiani d’America. Diede vita a luoghi remoti, Sant’Ilario dove vive una sua stagione una “Bocca di rosa”, via del Campo nel cuore di Genova. Nelle sue canzoni si materializzano dinanzi ai nostri occhi.
De André diede sempre molto fastidio alle vestali di ITA, le vergini dai candidi manti del tempo della prima repubblica, che, con tutto il suo marciume, era tutto sommato meno infame di questa. Gli toccò in sorte di morire naturalmente.
Non accadde come con altri personaggi altrettanto scomodi, non fu mandato nessun killer di Stato come nel caso di Pasolini. Ora anzi i servi mediatici di ITA, coloro che hanno fatto dell’assoluta ignoranza la loro scienza, della completa insipienza la loro cultura, ne parlano a vanvera, nella speranza di incasellarlo e di disinnescarlo. Ma invano.
Le sue canzoni non le possono cambiare, e dicono quello che dicono. L’anarchia, da sempre, è sintomo innanzi tutto di un disagio infinito nei confronti dello Stato presente. E le sue canzoni lo dicono benissimo, perfettamente.
Requiescat in pace.
I flebili balbettii buonistici dei videoeunuchi di ITA non ne modificheranno certo il messaggio.
Paolo Bernardini
If you liked my post, feel free to subscribe to my rss feeds
























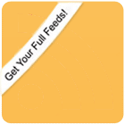
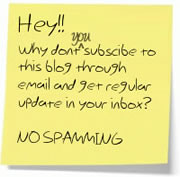
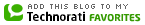

 Firma per il VENETO INDIPENDENTE!
Firma per il VENETO INDIPENDENTE! I 120 Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia
I 120 Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia Iutane, fa na picola donasion!
Iutane, fa na picola donasion! Veneto è chi il Veneto fa
Veneto è chi il Veneto fa il pnv su facebook
il pnv su facebook twitter
twitter Scottish National Party, SNP
Scottish National Party, SNP
 BlogoSquare
BlogoSquare