di Paolo Bernardini
ITA, 14 dicembre 2010. Il giorno del giudizio, Armageddon, il D-Day. Venduti e vendibili, mignotte e mignatte, semilavorati della vita e prodotti grezzi della dignità cedono al miglior offerente il proprio voto, “Ma sia umano, Cavaliere, mi paghi anche il mutuo della seconda casa, sa, casomai la sfiduciassero una seconda volta…” e così decidono delle sorti di un governo che la Costituzione vorrebbe essere espressione della volontà popolare. “Come fa schifo, il mio Paese”, dicevo da giovane. Ora, con i capelli brizzolati e molte rughe in più, dico semplicemente “questo Paese”; perché ho realizzato, per fortuna, che non è il mio. In questo modo, attenuo il dolore.
E’ un paese straniero, facilmente commutabile con un altro.

E così, come, sempre lavoro. Viaggio, penso, scrivo. E non sono certo il solo. E passa la mia giornata. Che dividerei da bravo regista in tre episodi, per dir così, significativi. Il film di un giorno come tanti, di una persona come tante.
- La chiamavano Trenità!
Como, ITA, 14 dicembre 2010. Decido di partire per Torino, voglio scrivere qualcosa sul Museo Lombroso, di cui ho parlato qualche giorno fa con Pino Aprile. Vorrei prendere il treno di Arenaways (www.arenaways.com), che collega Milano a Torino. Ma il coraggio dell’iniziativa privata deve scontare la nequizia e il protezionismo del monopolio pubblico. Gli orari sono impossibili per me, dovrei svegliarmi alle 4:30 per raggiungere in tempo la Stazione di Porta Garibaldi, e, a parte la nausea che mi provoca il nome della Stazione, proprio non ce la faccio. E il monopolista, Trenitalia, che in omaggio alla mia vocazione registica di oggi chiamerò Trenità, anche per simpatia per Terence Hill, naturalmente, l’ha vinta. Prendo un modesto trenino che parte alle 9:23 da Como San Giovanni. Non è in ritardo, ma è ghiacciato, il riscaldamento non funziona. Non si può avere tutto! Ma poi comincia anche ad essere in ritardo. Come sempre! In ogni caso, arrivo a Porta Garibaldi (Giuseppe o Anita?) (il disgusto per il “risorgimento” mi deriva anche dal fatto che tutte le donne che per ITA sono morte o si sono concesse non vengono mai e poi mai ricordate, sono solo uomini con lo spadone…) e passeggio tra i grattacieli in edificazione della nuova Milano fino a Centrale. La Stazione Centrale è stata sventrata, ha perso ogni dignità architettonica; in genere, e gli storici dell’architettura lo sanno bene, si modifica fortemente un manufatto quando viene alterata la sua funzione. Centrale è rimasta una stazione, ma è stata scavata al suo interno in modo vergognoso, se prima era decente, ora fa schifo. Ma ITA fa schifo, perché bisogna salvarne dei pezzi? Qualche amico dell’amico ci avrà fatto il suo bel bottino, dallo sbudellamento della Stazione.
 Arrivo su e al solito c’è la pubblicità filo-ITA di McDonald. Zaia ha fatto scuola, più di Benedetto Croce. C’è un’ITA di carnaccia disegnata su un hamburger, talmente ripugnante da far diventare vegetariana una tigre.
Arrivo su e al solito c’è la pubblicità filo-ITA di McDonald. Zaia ha fatto scuola, più di Benedetto Croce. C’è un’ITA di carnaccia disegnata su un hamburger, talmente ripugnante da far diventare vegetariana una tigre.
Ma la cosa più notevole è la scritta che graziosamente ci informa, noi poverini: dietro a tutta la “morbidezza” del pane utilizzato, c’è una “doppia levitazione”. Sic. Oh, ma allora questo pane degli angeli lo fanno proprio dei santoni, dei monaci zen, quelli di cui raccontava il giovane Fosco Maraini papà di Dacia, quelli che si vedono volare nei film di arti marziali, che sfidano la gravità e, appunto, levitano. O forse volevano scrivere “lievitazione”? Eh, questi alfieri dell’Italia unita e bella, delle magnifiche sue sorti progressive, e della toscana favella, che gli spot pubblicitari degli analfabeti prezzolati di turno ci dicono così superiore ai “dialetti” parlati da vil gente meccanica nei contadi pre-unitari, dalla plebe più volgare, dal volgo più plebeo; or bene, distinguer non sanno tra chi “levita” e chi “lievita”? Ohibò, ma questa è la farina del loro sacco? Mi piace pensare a cuochi del McDonald che cucinano le buone carni italiche, chianine e marchigiane e maremmane e podoliche, mentre stazionano a due metri da terra, LEVITANDO, appunto.
Però poi prendo il trenino per Torino. Mi guardo intorno, tante facce oneste e tristi e rassegnate, tanti lavoratori con abiti modesti e valigette al seguito, che lavorano e producono mentre una casta spregevole di governanti vende e compra il consenso ad un mercato che chiamerei delle vacche se non temessi di offendere i nobili animali da me appena citati. Il treno, con ritardo di mezz’ora, arriva a Torino. Scendo e mi avvio al museo. Tante facce tristi, che tirano innanzi, come burattini che hanno perso ogni speranza, ma non la dignità di chi lavora, produce, vive.
- Natural born brigands
 Il Museo Lombroso vale una visita. Si trova all’interno di un complesso universitario torinese, di fianco a Corso D’Azeglio – quello che diceva che i meridionali non erano uomini, e simili cosette – in via Giuria, “letterato” (ma confesso la mia ignoranza, non so chi sia); ad un passo da Torino Esposizioni, dalla reggia e del parco del Valentino. Il personale è gentilissimo e si può anche visitare l’adiacente Museo della Frutta – dopo tanti crani di briganti, assassini, prostitute e anarchici – mille pere e mele e patate coloratissime e riprodotte in una sorta di complessa materia assai più duttile della cera, costituisce un bel ristoro. Ora il problema del museo è che narra di una pagina non bella della scienza, pagina piena di razzismo, e di nefaste conseguenze, piena di hybris qual solo la scienza ottocentesca – che aveva perso quel Dio che Newton ancora aveva caro – poteva avere. La scienza che porta all’elettrochoc, e poi alle deportazioni, e poi agli stermini degli “anomali”. Lombroso ebbe una bella responsabilità in tutto questo, la sua teoria del “criminale nato”, che applicava con solerzia ai meridionali, ovviamente, lui ebreo veronese (eh caro Professor Lombroso poi toccò anche agli ebrei, ma Lei non lo vide); dell’atavismo, e molte altre gli hanno conquistato una fama sinistra.
Il Museo Lombroso vale una visita. Si trova all’interno di un complesso universitario torinese, di fianco a Corso D’Azeglio – quello che diceva che i meridionali non erano uomini, e simili cosette – in via Giuria, “letterato” (ma confesso la mia ignoranza, non so chi sia); ad un passo da Torino Esposizioni, dalla reggia e del parco del Valentino. Il personale è gentilissimo e si può anche visitare l’adiacente Museo della Frutta – dopo tanti crani di briganti, assassini, prostitute e anarchici – mille pere e mele e patate coloratissime e riprodotte in una sorta di complessa materia assai più duttile della cera, costituisce un bel ristoro. Ora il problema del museo è che narra di una pagina non bella della scienza, pagina piena di razzismo, e di nefaste conseguenze, piena di hybris qual solo la scienza ottocentesca – che aveva perso quel Dio che Newton ancora aveva caro – poteva avere. La scienza che porta all’elettrochoc, e poi alle deportazioni, e poi agli stermini degli “anomali”. Lombroso ebbe una bella responsabilità in tutto questo, la sua teoria del “criminale nato”, che applicava con solerzia ai meridionali, ovviamente, lui ebreo veronese (eh caro Professor Lombroso poi toccò anche agli ebrei, ma Lei non lo vide); dell’atavismo, e molte altre gli hanno conquistato una fama sinistra.
Che forse, ad essere onesti, non meritava. Alla fine della vita come Sant’Agostino, un santo laico, lui, così positivista, così fiero della sua cattedra e del suo laboratorio, e della sua devozione alla “scienza”, scrisse una sorta di “retractationes”, rendendosi conto con molta onestà intellettuale degli errori (molti, troppi?) da lui compiuti.
Ma ormai la scienza razzistica era avanzata abbastanza da permettere a solerti operai di aprire i cantieri di Auschwitz, ispirandosi magari a quelli di Fenestrelle, prigione-lager sabaudo (che il professor Lombroso ben conosceva). Insomma, come esistono musei sugli orrori del comunismo (a Budapest uno esemplare) sull’Olocausto (in ogni dove) c’è anche il museo Lombroso: non necessariamente i musei devono parlare di pagine corrusche della storia dell’umanità; insomma, c’è stato Caravaggio, nella storia del mondo, ma anche Himmler.
Solo c’è una certa ambiguità, qui e ora, nell’allestimento. Qualcosa di buono, oltre la buona volontà, glielo si deve concedere? Non so. Una saletta è per il “brigante” Villella. Nella forma del suo cranio Lombroso aveva individuato tratti e forme che a suo dire erano propri, fisicamente, dei criminali nati. Un video mostra scienziati recenti tutti intenti a mostrare che non è vero, che quelle pieghe tra le ossa sono caratteristiche di molti crani (anche di persone per bene, anche di deputati e senatori, giornalisti e professori…). Ma insomma, credo, senza l’odioso didascalismo del video, lo si dovrebbe ben capire (e sapere). Excusatio non petita…I discendenti del Villella hanno chiesto indietro, credo per vie legali, il cranio in questione (http://www.neoborbonici.it/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3582&Itemid=99). Ma intanto le didascalie ci dicono di lui tante cose brutte, di questo infelice alto “1007 mm”, insomma un metro. Pensare, classificare, misurare. La grande scienza dell’Ottocento. Che ebbe ad Auschwitz il suo trionfo, il suo Nobel postumo, la sua glorificazione.
Ma insomma, cum grano salis, questo museo val la pena visitarlo.
Esco, e passeggio al Valentino. A pochi passi dalla statua del severo D’Azeglio, questo nobile imbratta-tele razzista, fatuo e demagogo – che rende perfino più amabile Cavour, che aveva almeno la stoffa del delinquente vero, e di cui certamente sarebbe stato interessante misurare il cranio – su di una panchina al sole, due ragazze, una bionda dai capelli ricci ed una nera, probabilmente africana, dalla lunga treccia, si baciano teneramente. Mi portano alla mente una poesia di Baudelaire, un “fiore del male”. Chissà quali deformazioni nei loro crani!! Meno male che la statua di D’Azeglio guarda a nord. E volge loro le spalle. Se le vedesse, qual turbamento!
- Brains on the Run
 Palazzo Nuovo, Università di Torino, Facoltà di Lettere, tardo pomeriggio. Incontro una cara amica. Mentre l’aspetto, sulle scale d’ingresso, noto una scultura strana. Scatole di cartone vuote con un cervello disegnato, pile di scatole, e sopra la pila più alta, una scritta: “Cervelli in fuga”. La storia che si ripete. Nella vecchia, celebre pubblicazione “Cervelli in fuga”, del 2001, c’ero anche io. C’era uno dei maggiori filosofi del nostro tempo, un romano-de’-Roma, che allora era in fuga, tra lamenti e nostalgia, poi è tornato, per “fuggire” di nuovo. Come succede quasi a tutti. Solo chi ha il senso del martirio o è legato alla propria famiglia e città in modo quasi morboso rimane qui, ad insegnare nelle università di ITA. Almeno chi vuol lavorare. Per chi vuol vivere di rendita, e anche con un pur minimo prestigio sociale, vanno benissimo. Alcuni ragazzi lì intorno. Cerco di parlare con loro. Voglio dire che so di cosa si tratta, da trenta anni. Che in quel famoso libro c’ero anche io. Che ho sempre scritto in ogni dove il mio dissenso verso cotale sistema universitario. Ma mi prendono per uno scemo, sai quelli che vanno in giro nei campi di battaglia, a Omaha Beach, e dicono ai giovani, “Ninin, nel giorno più lungo c’ero anche io”, e i ragazzi gli rispondono, “Sì sì, va’ a fartene un’altra…e magari gli allungano cinque euro per un cognac”.
Palazzo Nuovo, Università di Torino, Facoltà di Lettere, tardo pomeriggio. Incontro una cara amica. Mentre l’aspetto, sulle scale d’ingresso, noto una scultura strana. Scatole di cartone vuote con un cervello disegnato, pile di scatole, e sopra la pila più alta, una scritta: “Cervelli in fuga”. La storia che si ripete. Nella vecchia, celebre pubblicazione “Cervelli in fuga”, del 2001, c’ero anche io. C’era uno dei maggiori filosofi del nostro tempo, un romano-de’-Roma, che allora era in fuga, tra lamenti e nostalgia, poi è tornato, per “fuggire” di nuovo. Come succede quasi a tutti. Solo chi ha il senso del martirio o è legato alla propria famiglia e città in modo quasi morboso rimane qui, ad insegnare nelle università di ITA. Almeno chi vuol lavorare. Per chi vuol vivere di rendita, e anche con un pur minimo prestigio sociale, vanno benissimo. Alcuni ragazzi lì intorno. Cerco di parlare con loro. Voglio dire che so di cosa si tratta, da trenta anni. Che in quel famoso libro c’ero anche io. Che ho sempre scritto in ogni dove il mio dissenso verso cotale sistema universitario. Ma mi prendono per uno scemo, sai quelli che vanno in giro nei campi di battaglia, a Omaha Beach, e dicono ai giovani, “Ninin, nel giorno più lungo c’ero anche io”, e i ragazzi gli rispondono, “Sì sì, va’ a fartene un’altra…e magari gli allungano cinque euro per un cognac”.
 Ma io c’ero. Ci sono. So cosa vuol dire, da trent’anni. I migliori studiosi di ITA lavorano fuori da ITA, si sa. L’università qui è un modesto ufficio di stato, dove si fanno firme e controfirme e verbali e controverbali da veri burocrati, e basta. Qualcuno fa ricerca, senza mezzi, senza niente. Se non ha parenti in cattedra si sente anche solo, senza famiglia, perché l’università di ITA è tutto un affare di famiglia (allargata, a comprendere famuli, amanti, amichette e amichetti). Va bene dai, con la mia vecchia, cara amica, ci scaldiamo, sul far della sera, con la semplice gioia di rivederci. Invecchiamo, è vero. Ma scriviamo, e continuiamo a mantenere una certa dignità nel nostro mestiere. Non gliene frega a nessuno. Salvo a noi stessi, ed è già abbastanza. Ci consoliamo con una splendida cioccolata calda da Baratti, in Piazza Castello. Con panna. 5.5 euro, ben spesi. Poi ritorno su “Trenità”, ritardo di mezz’ora per arrivare a Milano, e di 58 minuti per arrivare dalla Stazione di Porta Anita Garibaldi (lasciatemi il piacere di rinominarla così), a Como.
Ma io c’ero. Ci sono. So cosa vuol dire, da trent’anni. I migliori studiosi di ITA lavorano fuori da ITA, si sa. L’università qui è un modesto ufficio di stato, dove si fanno firme e controfirme e verbali e controverbali da veri burocrati, e basta. Qualcuno fa ricerca, senza mezzi, senza niente. Se non ha parenti in cattedra si sente anche solo, senza famiglia, perché l’università di ITA è tutto un affare di famiglia (allargata, a comprendere famuli, amanti, amichette e amichetti). Va bene dai, con la mia vecchia, cara amica, ci scaldiamo, sul far della sera, con la semplice gioia di rivederci. Invecchiamo, è vero. Ma scriviamo, e continuiamo a mantenere una certa dignità nel nostro mestiere. Non gliene frega a nessuno. Salvo a noi stessi, ed è già abbastanza. Ci consoliamo con una splendida cioccolata calda da Baratti, in Piazza Castello. Con panna. 5.5 euro, ben spesi. Poi ritorno su “Trenità”, ritardo di mezz’ora per arrivare a Milano, e di 58 minuti per arrivare dalla Stazione di Porta Anita Garibaldi (lasciatemi il piacere di rinominarla così), a Como.
A casa alle 11, si conclude così la mia avventura sabauda. Agrodolce. Molto agra, poco dolce. Quanto manca all’indipendenza della Venetia, della Sardegna, della Liguria? Facciamo presto, sto invecchiando.
WSM
Paolo L. Bernardini
If you liked my post, feel free to subscribe to my rss feeds
























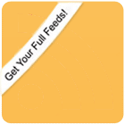
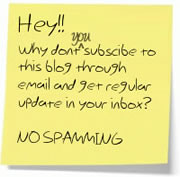
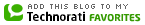

 Firma per il VENETO INDIPENDENTE!
Firma per il VENETO INDIPENDENTE! I 120 Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia
I 120 Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia Iutane, fa na picola donasion!
Iutane, fa na picola donasion! Veneto è chi il Veneto fa
Veneto è chi il Veneto fa il pnv su facebook
il pnv su facebook twitter
twitter Scottish National Party, SNP
Scottish National Party, SNP
 BlogoSquare
BlogoSquare