Genova, una storia che non cambia. Per ora.

Il 7 ottobre 1970 era un giorno di pioggia come gli altri, come da quando era iniziata la scuola, il primo del mese. Lo ricordava allora, questo inizio, una canzone tristissima, nella sua apparenza di allegria: “E’ il primo ottobre, a scuola si va, e ci accompagnano mamma e papà”; triste, e infelice, quel motivetto da Zecchino d’Oro, perché molti bimbi non avevano né hanno mamma e papà, oppure hanno solo la mamma o solo il papà. Oppure hanno entrambi, ma nessuno di loro li accompagna a scuola.
All’ultimo piano della scuola elementare Colombo, dedicata all’eroe cittadino – ora quell’edificio ospita un ufficio per le pratiche funerarie, la denatalità genovese è tra le prime al mondo, i morti rimpiazzano i vivi in ogni dove, come nel celebre dipinto di Peter Brueghel – eravamo più o meno in venti, alcuni erano rimasti a casa perché si prevedeva il peggio. Da giorni. E il peggio arrivò.
L’atmosfera non era delle migliori, la maestra, una bellissima signora della Foce, il quartiere che ospitava la scuola, cercava di farci capire che c’era “qualche rischio”, in città, che forse saremmo rimasti a scuola anche nel pomeriggio, e che comunque non dovevamo preoccuparci. Finché un’altra maestra, più giovane, era entrata sorprendentemente in classe, e aveva detto piano alla nostra: “L’acqua è in via Venti Settembre”. Piano, ma non abbastanza perché qualcuno di noi non afferrasse le parole.
Eravamo, nei nostri grembiuli lindi, bianchi per le femmine, blu per i maschi, delle specie di uova di pasqua, con tanto di fiocco azzurro e rosa rispettivamente. In breve, qualcuno cominciò a piangere. Io e il mio amico Umberto – siamo amici dall’asilo, tra un po’ da mezzo secolo – eravamo molto incuriositi, più che altro, ed essendo via Venti Settembre, la grande arteria “parigina” di Genova una strada nel pieno centro e in salita, anche veramente spaventati. L’acqua che raggiunge una strada in salita e la percorre dev’essere davvero irresistibile, immane. Sfida la gravità. Il mio amico Roberto si mise a piangere. Chissà se quell’evento influì sulla decisione del suo fratellino, allora di pochi anni, di diventare un valente vigile del fuoco (e dell’acqua, naturalmente, visti i compiti molteplici dei pompieri). Anche allora, come nella canzoncina di Cocciante, “era già tutto previsto”.
La maestra interruppe la lezione, ci spiegò brevemente che il Bisagno aveva “tracimato”, “rotto”, e di star calmi, che noi lassù al sesto piano eravamo al sicuro. “Ma il Bisagno scorre qui sotto!”, disse una bimba a gran voce. In effetti, il letto del Bisagno, eponimo di una gloriosa brigata di partigiani e di un altrettanto glorioso comandante, si trova a poche centinaia di metri da quell’edificio, prima di interrarsi per un chilometro o poco più e finire in mare. Insomma, bastava far la cosa più semplice, per capire in che situazione ci trovavamo: guardare fuori dalla finestra.
La maestra ce lo voleva blandamente impedire ma a sette anni l’istinto di sopravvivenza è forte, e, mentre qualcuno piangeva – più maschietti che femminucce, ad essere onesti – noi andammo alla finestra. Dovevamo sporgerci un po’, certo, ma sotto vedemmo chiaramente “l’acqua”. Corso Torino era un fiume, l’acqua era quasi nera. Trasportava cose. E forse persone. Che ne sarebbe stato di noi? Eravamo al sicuro, certamente, questo era chiaro, per quanto immane fosse l’onda di piena non avrebbe mai scalato sei piani, ci sarebbe voluto uno tsunami di 30 metri, un’onda dal mare a un chilometro da noi, verso sud, per spazzarci via. Il Bisagno, il fiume che dà il nome a Genova ai verdurai, i “besagnin”, lassù nel nostro rifugio non sarebbe mai arrivato.
Ma come saremmo tornati a casa? Aspettammo fino al primo pomeriggio, l’acqua a quel punto era scesa parecchio, rimanevano strati di fango. Almeno in corso Torino. E ricordo mio nonno Jean, dal singolare nome francese, ma era genovesissimo, con il suo paltò grigio, ad aspettarmi nel fango quando finalmente ci fecero scendere le scale, perché si poteva evacuare la scuola e raggiungere la casa. Per me e mio nonno, atleta olimpionico ai tempi del duce, gran corridore – mi acchiappava quasi sempre sullo scatto breve quando cercavo di eludere la sua sorveglianza, a Genova, per andare ad esplorare la città da solo, avevo sei anni, o sette, e prendevo gli autobus dai numeri insoliti per vedermi un po’ di mondo, terrorizzando i miei – ricordo il mio nonno Jean che mi aveva portato un paio di stivali neri, altissimi, da pesca, che non avevo mai visto ma che miracolosamente erano il mio numero. Li indossai sui gradoni della porta, ancora piovigginava, insieme ad un pesante cappotto, da emergenza. Al suo braccio percorsi quelle centinaia di metri che dividevano da casa, quando Corso Torino diventa tuttora via Rimassa, si apre al mare. Ma l’acqua c’era ancora, in molte strade limitrofe, parallele o trasversali.
Salutai il mio amico del cuore Umberto ma per lui la sorte fu diversa. Infatti nella via Maddaloni dove viveva, una laterale di Corso Torino, ma esposta più ad ovest, l’acqua era ancora altissima e a casa lo portò in braccio un vigile; l’acqua gli arrivò quasi al petto e il povero Umberto tornò a casa fradicio, e terrorizzato: per lui l’alluvione del Settanta volle dire una broncopolmonite, mesi di malattia.
Ma per me fu anche peggio, perché l’alluvione mi strappò la mia nonna più cara, la persona che mi stava più vicino – i miei lavoravano dal mattino alla sera per cercare di tirare avanti, era nato da gennaio mio fratello, ed eravamo molto poveri – la nonna Delia. Delia era giovane, era la madre di mio padre. Non l’uccise l’acqua direttamente, ma il dolore, il dolore di aver perso tutto quello che aveva. Faceva la venditrice ambulante di intimo femminile, e le sue mercanzie erano tutte stipate in uno scantinato che venne invaso dall’acqua. Soffriva già di cuore, ma questo colpo l’uccise. E tempo dopo ricordo sempre nonno Jean, con un’espressione differente, venirmi a prendere nella scuola riaperta, in una giornata di sole, ma con il volto che ben diceva quel che era accaduto, e quel che doveva pur dirmi, lui, prima di mio padre, che lavorava sempre.
Così in quei giorni di Ottobre che ricordo benissimo, i tiranni vorrebbero sottrarci anche la memoria ma non ci riescono, Genova, che amavo allora come ora, venne sommersa dall’acqua. Morirono in quarantaquattro, se non ricordo male. Tanti come i gatti di un’altra canzone dello Zecchino d’Oro. Ma fecero la fine dei topi, piuttosto. E poi di nuovo nel 1977, nel 1990, nel 1992, nel 1999. Nel 1992 mio padre perse solo delle bottiglie di vino francese di grande valore, che aveva vinto per un nonnulla ad un’asta di mobili. Avremmo dovuto berle prima!
Ora, nel giorno 4 novembre, la celebrazione della fine di un massacro di innocenti voluto intensamente e intensamente perpetrato da Stati beceri, criminali, violenti, e traditori, in cui ITA primeggia per schifo, in cui il rosso-vergogna della bandiera emana lampi sinistri, compiacendosi dei 600.000 bambini mandati al macello per niente, e neanche ricordati – se c’è un abominio che grida vendetta al cospetto d’ogni Dio che alberghi in ogni fede questo è il milite ignoto, morti senza volto e senza nome infangati dalla protervia lancinante dello Stato, che pretende d’esser l’unico ad erigerne un avello e tesserne il ricordo – Genova è stata colpita di nuovo. Chissà che brividi avranno toccato il giornalista di Rete4 Alberto Pastanella, nel raccontare la sciagura. Era un bambino anche lui in quella stessa Foce, nel 1970, sua mamma aveva un negozio di fiori ad un passa da casa mia, che fu distrutto anch’esso. Ora sa raccontarci bene quel che è successo, ma le immagini sono le stesse di allora, i luoghi gli stessi di allora, i morti sono sempre tragicamente la stessa cosa in ogni tempo e in ogni luogo.
Certo, i morti sono solo sette, oggi. Solo… Quando la Liguria tornerà ad essere indipendente, finalmente saranno affrontati i problemi colossali legati a quei torrenti apparentemente insignificanti, come il Fereggiano, che non riescono però a sostenere le piogge torrenziali, e diventano micidiali assassini quando queste si presentano. Lo sanno benissimo i cosiddetti “amministratori locali”, questi piccoli feudatari di Roma a cui tocca qualche briciola del bottino, che si contendono come porci in un’arena di sterco, sperando anche loro di essere beneficiati un giorno dal grosso del furto, che spetti anche a loro, ad esempio, una Maserati in premio, ad esempio, come ai generalissimi di ITA, i Patton e gli Eisenhower di questa tragicommedia farsesca di paesino che non rinuncia, in casi come questo, a diventare vero e proprio dramma elisabettiano. L’infimo dell’imo, avrebbe scritto un poeta genovese. Un altro, del resto, avevo scritto, molto tempo prima: “Non c’è limite al peggio”.
Così, mentre i generali d’Italia proveranno il brivido unico di accendere un motore Maserati, il cui rombo è ineguagliabile, i genitori dei bimbi morti a Genova non per la furia degli elementi, ma per l’incapacità della politica ad affrontare un problema chiaro e noto e sempre latente, e per l’incapacità di un sindaco inqualificabile che ben sapeva dell’imminenza di questa nuova sciagura ma che ha lasciato che tutto andasse come se niente fosse, proveranno un brivido diverso nel veder sepolte a Staglieno le loro figlie, prima bambine e ora salme.
Non sarà come accendere un motore Maserati, ma come lo spegnersi di ogni speranza, che emana un rumore lieve e sordo, vago e incerto, perché se libero corso si lasciasse al dolore, sarebbe un urlo immane da soffocare la terra, da alluvionare il mondo.
Sono felice che il fiume in piena, in quel giorno di Ottobre di 41 anni fa, non mi abbia portato via. La sicura guida di mio nonno, che morì molti anni dopo alla soglia dei 100 per un attacco d’ernia, mi fece arrivare a casa intatto.
Ma certamente il fiume dei popoli esarcebati cui appartengo dovrà spazzar via il marciume che porta a queste tragedie, il marciume di un’ITA corrotta in tutte le sue fibre, incapace di affrontare problemi noti, confidando nel destino: “Speriamo bene! Speriamo che non piova…” avranno pregato insieme sindaco giunta e consiglieri di regione, tutti i simulacri di essere umano che il governo centrale usa per far credere che esista un’ombra di autonomia.
E’ quel che si prega quando si esce per andare a fare una scampagnata, per andare a bere vino rosso e mangiar panini al salame a Sant’Olcese, all’Acquasanta.
Non quando la vita di una città è a rischio.
Se il Bisagno mi ha graziato quel giorno di Ottobre, spero lo abbia fatto anche perché possa contribuire a por fine a questa indecenza che si chiama ITA, indipendentemente dal fatto che sia sempre stata così tragicamente inadeguata e indecorosa, o lo sia diventata nel tempo. Mi dispiace pr voi, suoi infimi servi, ma l’acqua quel giorno, quel sette di ottobre 1970, mi ha soltanto sfiorato.
Paolo L. Bernardini
If you liked my post, feel free to subscribe to my rss feeds
























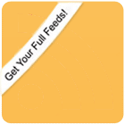
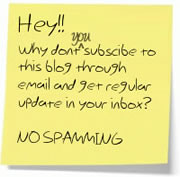
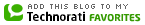

 Firma per il VENETO INDIPENDENTE!
Firma per il VENETO INDIPENDENTE! I 120 Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia
I 120 Dogi della Serenissima Repubblica di Venezia Iutane, fa na picola donasion!
Iutane, fa na picola donasion! Veneto è chi il Veneto fa
Veneto è chi il Veneto fa il pnv su facebook
il pnv su facebook twitter
twitter Scottish National Party, SNP
Scottish National Party, SNP
 BlogoSquare
BlogoSquare
Intanto questa povera gente soffre e muore per colpe non sue.
Mi ricorda il disastro alluvionale Veneto di un anno fa.
Il sindaco genovese affermava ( senza dimostrarlo con le carte ) che erano stati stanziati 3 milioni di euro per il contenimento delle acque del torrente esondato.
Lavori ufficialmente eseguiti.
Salvo poi apprendere dalle testimonianze televisive a cui ho assistito, che le imprese chiudevano i cantieri in fretta e furia, perchè secondo loro i margini di guadagno erano insignificanti.
Come saranno stati svolti quei lavori ? 🙁
Caro Crisvi,
e come vuoi che siano stati svolti? Diciamo pure che nel Veneto indipendente se un amministratore locale si macchierà dei crimini della Signora Marta Vincenzi, sarà costretto a dimettersi.
Cordialmente
Paolo
Caro Paolo,
Io spero che ladri e ” furbastri ” che speculano su sicurezza, salute e vita della gente siano non solo licenziati, ma definitivamente puniti.
Esiste una stele in pietra apposta sulla torre campanaria in Piazza dei Signori di Vicenza.
Nella stessa si riporta come fu bandito per sempre dai territori serenissimi, dopo adeguato periodo di carcerazione, un camerlengo amministrativamente infedele dell’epoca.
Ecco come io intendo la futura matrice dello Stato Veneto indipendente : carcere duro ( anche lavori socialmente utili obbligati ) e allontanamento perpetuo da queste nostre terre serenissime a chi si macchia di reati che mettano a rischio il benessere, la salute, la vita dei nostri cittadini.
Riguardo Genova e la sua alluvione, l’attuale giunta fu oggetto nel 2008 di un’inchiesta penale per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione.
Furono arrestati il portavoce del sindaco, Stefano Francesca, insieme a due ex consiglieri comunali, Massimo Casagrande e Claudio Fedrazzoni ed altri. Indagati, a piede libero, anche due assessori della Giunta comunale, Massimiliano Morettini e Paolo Striano.
Ho ancora l’odore del fango e della melma insalubre che spalavo lo scorso anno, per aiutare dei conoscenti nelle zone di Cresole, Caldogno.
Non contento, grazie a un gruppo di associati, abbiamo donato una somma che ho portato personalmente in qualità di Presidente, a una famiglia devastata dall’alluvione.
La ricevuta per traenza è agli atti contabili.
Ricambio il tuo saluto con viva cordialità.
WSM 🙂
NB: ” Ho ancora l’odore del fango e della melma insalubre che spalavo lo scorso anno….”
Nel naso, conservo ancora il ricordo dell’odore del fango e della melma insalubre che spalavo lo scorso anno….
Sì, nel Veneto indipendente sarà così. Lavoriamo insieme per costruirlo, tutti. Spero proprio che le divisioni emerse in VS si ricompongano.
Difficile che le divisioni si ricompongano, quando manca la chiarezza di base.
Personalmente sono quotidianamente interpellato da scontenti, che non riscontrano in VS la loro casa comune.
Forse non lo sai Paolo, ma hanno ” stracciato ” la propria tessera politica, persino alcuni fondatori della prima ora del PNV e di VS.
Fino a poco più di una settimana fa, nella fazione primaria, chiedevano la testa di GLBusato e GLPanto.
Leggi l’appello di GL Busato in questo blog, se hai qualche dubbio.
https://www.pnveneto.org/2011/10/linciaggio-e-disinformatia/
Personalmente se avessi titolo nel partito, non mi priverei della loro collaborazione, neppure se offendessero la memoria dei miei morti. ( al max rifilerei un pugno sul naso cadauno 😀 )
Temo in una deriva personalistica.
Il neo Presidente non mi ha affatto convinto, specie dopo il suo discorso d’insediamento.
Il nuovo segretario lo sto ancora valutando.
Dovrei ricevere a breve il filmato della accesissima ( da dimenticare ) riunione del mC al Viest di Vicenza, voglio rivedere i passaggi essenziali per rifletterci maggiormente.
Specie su alcune disgustose sceneggiate napoletane che ricordo.
Ti rendi conto, se un filmato del genere finisse su youtube, cosa accadrebbe all’immagine di VS ?
In termini politici sono deluso, delusissimo, come mai prima d’ora 🙁 …………………..più volte durante l’assemblea ho cercato nel mio piccolo di invitare alla calma, ma il capo orchestra aveva ben sistemato i suoi inarrestabili coristi.
Il concerto l’ha iniziato il Presidente uscente, che non ha trovato di meglio che togliersi pubblicamente ” i sassi dalle scarpe “, contro altri fondatori.
Di contraltare, ho conosciuto o riveduto, tanti bravissimi militanti riflessivi.
Molti di loro li conoscevo già, con altri ho conversato garbatamente per la prima volta.
Un reciproco arricchimento culturale e politico.
Quando ho scritto questo, in totale rispetto della netiquette web, l’unica alternativa del direttivo è stata quella di ordinare al moderatore 21enne ( che mi conosce da anni e ha manifestato sempre rispetto nei miei confronti ) di bannarmi da VS.org.
Analoga fine hanno fatto tutti i commentatori sgraditi al nuovo esecutivo.
Lascio poi giudicare a te questo intervento dell’ Alessia Bellon, non voglio aggiungere altro a quanto precedentemente espresso :
http://www.venetostato.com/2011/11/serata-sulle-ragioni-economiche-dellindipendenza/
Quando, conoscendo le mie simpatie indipendentiste, soci, colleghi, clienti, associati, volontari , ecc. mi chiedono cosa ne penso del partito indipendentista Veneto rispondo :
” le nespole non sono ancora mature ”
Ti saluto con viva cordialità. ” Panta rei ” come si suppone esclamasse Eraclito.
WSM
Crisvi 🙂